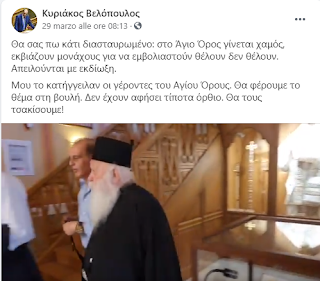|
La prima pagina della lettera
alla Sacra Comunità Athonita |
Diamo spazio a questa importante riflessione pubblicata già qualche mese fa dall'Associazione "Testimonianza Ortodossa", che tra le altre cose gestisce una casa editrice che ha pubblicato numerosi titoli di patristica e spiritualità ortodossa in italiano, di grande attualità nel momento presente. Nei giorni scorsi un testo simile, alla cui stesura ha collaborato la predetta Associazione, è stato diffuso dall'Associazione greca "IC XC NIKA", in forma di lettera diretta al Santo Sinodo di Grecia, al Santo Sinodo di Cipro e alla Sacra Comunità del Monte Athos, che tratta - oltre alla parte sui vaccini sostanzialmente simile a questa - pure delle "misure di contenimento del contagio", non di rado contrarie ai canoni e blasfeme, che in molti luoghi stanno venendo applicate, e che è stata firmata da quasi 2000 persone tra sacerdoti, monaci, medici, teologi e altri.
È MORALMENTE ACCETTABILE UN VACCINO COSTRUITO
CON CELLULE PRELEVATE DA UN ABORTO?
Riflessioni morali per i cristiani ortodossi circa i preparati vaccinali
a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti
Tra scienza e salvezza
Dal punto di vista della prevenzione di malattie infettive e contagiose molto gravi, che in passato hanno causato migliaia di morti, è chiaro che i vaccini sono stati una grande conquista per l’umanità, e il loro impiego nella lotta contro le infezioni fino alla loro eradicazione, mediante una immunizzazione delle popolazioni interessate, rappresenta indubbiamente una “pietra miliare” nella lotta dell’uomo contro le malattie infettive e contagiose.
Lo scopo dei vaccini è quello di sensibilizzare il sistema immunitario, con l’ingresso all’organismo umano di un agente patogeno attenuato. In questo processo, il sistema immunitario produce, da un lato, anticorpi per distruggere il nemico e, dall’altro acquisisce una memoria, in modo che se incontra in seguito lo stesso agente patogeno può riconoscerlo e agire in modo distruttivo.
Nella frenesia dell’ingegneria genetica, tuttavia, l’uomo non ha esitato a utilizzare anche procedure che dal punto di vista etico non sono accettabili, con la motivazione che lo scopo santifica i mezzi. Così, abbiamo raggiunto il punto in cui alcuni vaccini in circolazione sono preparati o vengono utilizzate per la loro preparazione sperimentale cellule umane raccolte nei tessuti di feti infettati e volontariamente abortiti, infettati e successivamente attenuati e coltivati mediante ceppi di cellule umane ugualmente provenienti da aborti volontari, a noi di fede cristiana ortodossa si pongono importanti problemi etici.
La domanda che ci siamo posti e alla quale abbiamo cercato di dare una risposta è: chi usa un vaccino del genere, quanto coopera al male dell’aborto?
Destano particolare preoccupazione per noi i vaccini che sono stati realizzati utilizzando in parte il tessuto fetale derivato da aborti avvenuti decenni fa:
I vaccini per l’infanzia come il Varivax per la varicella, il Meruvax II per la rosolia, l’Havrix e il Proquad utilizzato per morbillo sono realizzati utilizzando in parte il tessuto fetale, e portano i nomi MRC-5 e WI-38 . Compreso il vaccino Vaqta per l’epatite.
La sigla WI-38 (Winstar Institute 38, istituto di ricerca biomedica) indica cellule fibroblasti di polmone umano espiantate nel 1964 da un feto femmina svedese abortito perché la famiglia riteneva di avere già troppi figli. Questa linea cellulare viene utilizzata ancora oggi per far crescere i virus utilizzati nei vaccini morbillo, parotite, rosolia, varicella ed herpes zoster.
La linea cellulare MRC-5 (Medical Research Council, istituto di ricerca) indica cellule polmonari umane provenienti da un feto maschio di quattordici settimane abortito nel 1966.
I ceppi di cellule utilizzati per il MRC-5 e il WI-38 provengono da bambini abortiti nel 1961.
Le loro cellule sono state rigenerate dalla Merck e da altre aziende, in laboratorio. Questi ceppi di cellule sono tecnicamente “immortali”, perché i tecnici possono conservarli indefinitamente nelle condizioni appropriate.
Vaccini contro il coronavirus e utilizzo di cellule di feti abortiti.
Con lo sviluppo di vaccini contro Covid-19 a un ritmo accelerato, è importante essere informati su come questi vaccini sono progettati, prodotti e testati. Esistono, infatti, questioni etiche sul possibile utilizzo, in qualunque fase del processo di sviluppo, di linee cellulari derivate da feti abortiti.
In particolare, le due case farmaceutiche, Moderna e Pfizer/BioNTech hanno utilizzato la serie di cellule HEK 293 nella fase dei test di laboratorio di conferma.
Astra/Zeneka (Oxford), che collabora con lo Sputnik, e la Jannsen usarono la serie di cellule HEK 293 in tutti e tre gli stadi: I. Progettazione e sviluppo; II. Produzione e III. Test di laboratorio di conferma.
Il Charlotte Lozier Institute negli Stati Uniti, sulla base di un’analisi approfondita della letteratura scientifica e dei risultati delle sperimentazioni cliniche, ha compilato un’accurata panoramica delle aziende farmaceutiche che utilizzano o non utilizzano linee cellulari eticamente controverse.
La domanda che sorge è se queste linee cellulari fetali siano assolutamente necessarie per lo sviluppo di un vaccino, e ultimamente il vaccino contro il Covid-19. La risposta è no. È possibile sviluppare vaccini eticamente accettabili senza cellule o basati su cellule animali, uova di gallina o lievito. Questo è fondamentalmente ciò che stanno facendo diverse società farmaceutiche.
Il passo successivo è acquisire informazioni sulle diverse fasi di sviluppo di un vaccino in cui sono utilizzare linee cellulari di feti abortiti.
La fase di progettazione include lo sviluppo del concetto, esperimenti preliminari e la descrizione di come verrà prodotto il vaccino.
Aziende farmaceutiche e istituti di ricerca che hanno utilizzato linee cellulari di feti abortiti in questa fase:
- Altimmune (USA)
- Astra Zeneca e Università di Oxford (Regno Unito, Stati Uniti)
- CanSino Biologics, Inc. Beijing Institute of Biotechnology, Academy of Military Medical Sciences,
PLA of China (Cina)
- Gamaleya Research Institute (Russia)
- Janssen Research & Development , Inc. Johnson & Johnson (USA)
- Vaxart (USA)
- Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical / Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences
(Cina)
- Università di Pittsburgh (USA)
La fase di produzione: viene prodotto il vaccino finale.
Aziende farmaceutiche e istituti di ricerca che utilizzano linee cellulari di feti abortiti in questa fase:
- Altimmune (USA)
- Astra Zeneca University of Oxford (Regno Unito, Stati Uniti)
- CanSino Biologics, Inc. Beijing Institute of Biotechnology, Academy of Military Medical Sciences,
PLA of China (Cina)
- Gamaleya Research Institute (Russia)
- Janssen Research & Development, Inc. Johnson & JohnsonVaxart (Stati Uniti)
- Vaxart (USA)
- Università di Pittsburgh (USA)
Fase di test del vaccino in laboratorio, prima che sia ampiamente distribuito. Aziende farmaceutiche e istituti di ricerca che utilizzano linee cellulari di feti abortiti in questa fase:
- Sinovac Biotech Co., Ltd. (Cina)
- Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical / Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (Cina)
- Medicago (Canada)
- Novavax (USA)
- Moderna, Inc. avec le National Institute of Health (USA)
- Pfizer et BioNTech (USA, Germania)
- Sanofi Pasteur et Translate Bio (USA, Francia)
- Inovio Pharmaceuticals (USA)
Le aziende farmaceutiche che non utilizzano linee cellulari fetali in una delle tre fasi sono (dal 10 novembre 2020, tenendo conto della fase di sviluppo del vaccino):
- Beijing Institute of Biological Products / Sinopharm (Cina)
- Wuhan Institute of Biological Products / Sinopharm (Cina)
- Istituto di ricerca medica Giovanni Paolo II (USA)
- Institut Pasteur e Themis e Merck (USA, Francia)
- Shenzhen Geno-immune Medical Institute (Cina)
- Merck e IAVI (USA)
- Clover Biopharmaceuticals, Inc. (Cina)
- Sanofi e GSK Protein Sciences (USA, Francia)
- Sorrento (USA)
- Università del Queensland e CSL Ltd. (Australia)
- CureVac (Germania)
- Genexin (Corea)
- Symvivo Corporation (Canada)
NB: Diverse aziende farmaceutiche non hanno ancora completato tutte le fasi del processo.
Il giudizio etico dei vaccini proposti può essere basato su diversi elementi:
- L’esistenza o meno di alternative ai vaccini sviluppati da linee cellulari di feti abortiti: laddove esistono e sono disponibili vaccini eticamente sviluppati, questi dovrebbero avere la priorità.
- Il grado di distanza, nel tempo ma soprattutto nella responsabilità, tra l’aborto in questione e il paziente vaccinato. Pertanto, la responsabilità del paziente da vaccinare è bassa rispetto a quella del ricercatore che utilizza queste linee cellulari e quindi stimola la produzione di linee cellulari simili.
- Le fasi del processo di sviluppo del vaccino, per il quale sono state utilizzate linee cellulari fetali.Se il vaccino che il paziente riceve è prodotto da queste linee cellulari fetali (Fase 2), stimola la produzione di nuove cellule fetali. Questa relazione è meno evidente quando l’azienda farmaceutica testa solo alcune copie del vaccino sulle cellule fetali (Fase 3).
Oltre a quanto è stato esposto il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (ACIP) ha emesso raccomandazioni ad interim per l’uso dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna COVID-19 per la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli Stati Uniti.
Entrambi i vaccini sono vaccini a mRNA che codifica la proteina spike di SARS-CoV-2, una proteina presente sulla superficie esterna del virus, utilizzata per entrare nelle cellule e replicarsi. Il vaccino a mRNA fornisce le informazioni genetiche appropriate, in modo che le cellule dell’ospite (l’umano) siano indotte alla produzione di una risposta immunitaria. La creazione di anticorpi e cellule T-(linfo). Questo progetto che è ideale in vitro (in laboratorio), tuttavia devia dalle aspettative se applicato in vivo. Un semplice esempio è la comparsa di effetti collaterali e che non si può prevedere gli effetti che potrebbe avere nell’organismo umano a lungo termine.
CONCLUSIONI
Il Concilio Ecumenico Quinisesto o di Trullo con il suo XCI Canone condanna alla pena prevista per gli assassini le donne (o gli uomini) che forniscono farmaci per procurare l’aborto, e quelle che assumono veleni per uccidere i feti.
Il Concilio regionale tenutosi ad Ancyra con il suo XXI Canone condanna a dieci anni di scomunica coloro che agiscono in modo da procurarsi un aborto.
Il II e il LXXX Canone di San Basilio condanna alla pena prevista per gli assassini donna che abortisce volontariamente.
Ogni atto medico e di ricerca, per essere secondo l’insegnamento divino, deve rispettare l’uomo, dal momento del suo concepimento fino alla morte, in generale,essere secondo la lettera e lo spirito del Vangelo. Per questo motivo, la scelta di vaccinarsi o no è anche una questione teologica ed ecclesiastica, e l’accettazione di questi vaccini, considerando le condizioni della loro produzione, è una caduta dalla retta fede e vita.
Per questi motivi è nostra convinzione che:
1. Quelli che procurano i tessuti dai bambini abortiti, sono colpevoli di cooperare formalmente all’aborto approvandolo e sfruttando l’atto stesso dell’aborto. Essi sono colpevoli come lo sono coloro che cooperano.
2. Sono colpevoli coloro che mettono in commercio, pubblicizzano e distribuiscono i vaccini derivati. Queste attività sono moralmente illecite, perché potrebbero “contribuire, di fatto, a incentivare l’effettuazione di altri aborti volontari, finalizzati alla produzione di tali vaccini.
Tuttavia, questo provoca una costrizione morale sia ai genitori, per quel che riguarda i vaccini per l’infanzia, che sono sottoposti all’alternativa di agire contro coscienza o mettere in pericolo la salute dei propri figli, sia a ogni cittadino per quel che riguarda i vaccini contro il coronavirus. Si tratta di un’alternativa ingiusta che deve essere eliminata quanto prima.
Certamente non ci soddisfa ne posiamo condividerla l’argomentazione di molti che le linee cellulari utilizzate sono distanti dagli aborti originali, né ci soddisfa l’argomentazione di mettere da parte ogni questione etica perché è per il nostro bene. Crediamo che non possa essere nulla di buono se è nato dal male. Il fine non giustifica i mezzi.
Oltre il problema etico esiste anche la libertà vaccinale, il così detto consenso informato.
Il consenso informato è la manifestazione di volontà che il paziente esprime liberamente in ordine ad un trattamento sanitario. Il termine “consenso informato” nasce dopo il processo di Norimberga, quando l’omonimo codice evidenziò il principio dell’inviolabilità della persona umana: la partecipazione di qualunque individuo ad una ricerca scientifica non sarebbe più avvenuta senza il suo volontario consenso.
L’obbligatorietà del consenso informato come condizione per la liceità della ricerca viene sancita nel 1979 dal Rapporto Belmont nel rispetto del principio di giustizia, di benefici e del principio di autonomia. Il caso giudiziario che, nel nostro Paese, ha destato l’attenzione del mondo sanitario e giuridico sul problema del consenso, è rappresentato dalla sentenza della Cass. Pen. n. 5639/1992 (Caso Massimo) che condannò un chirurgo per il reato di omicidio preterintenzionale a seguito del decesso di una paziente avvenuto a causa delle complicanze di un intervento chirurgico demolitivo eseguito senza il suo consenso. Da allora il tema del consenso ha assunto una rilevanza sempre crescente.
L’obbligo per il medico di munirsi del valido consenso della persona assistita trova riscontro nella stessa Costituzione dai seguenti articoli:
Art.13: sancisce l’inviolabilità della libertà personale
Art.32: riconosce che nessuno può essere obbligato a determinati trattamento sanitari se non per disposizione di legge e dall’art. 13 che sancisce l’inviolabilità della libertà personale.
Dei riferimenti li ritroviamo anche nell’art. 50 del Codice Penale (rubricato “consenso dell’avente diritto”).
Il consenso informato valido deve essere:
- personale: espresso direttamente dal soggetto per il quale è previsto l’accertamento, salvo i casi di incapacità, riguardanti i minori e gli infermi di mente;
- libero: non condizionato da pressioni psicologiche da parte di altri soggetti;
- esplicito: manifestato in maniera chiara e non equivocabile;
- consapevole: formato solo dopo che il paziente ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per maturare una decisione;
- specifico: in caso di trattamento particolarmente complesso, l’accettazione del paziente deve essere indirizzata verso tali procedure, mentre non avrebbe alcun valore giuridico un consenso del tutto generico al trattamento. In alcune situazioni particolari, come per esempio quelle relative ad un intervento chirurgico nel caso in cui non ci fosse certezza sul grado di espansione ed invasione di una neoplasia, si ricorre al consenso allargato.
Il consenso informato è un diritto riconosciuto in tutto il mondo, garantito dai seguenti trattati internazionali per la protezione dei diritti umani:
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di ROMA/ 1950 (CEDU).
- Convenzione Internazionale di Bioetica di OVIEDO / 1998.
- Statuto della Corte penale internazionale dell’Aia - Articolo 7.
- Codice di Norimberga.
- Dichiarazione di Helsinki.
- Dichiarazione Universale su Bioetica e Diritti Umani-UNESCO / 1950.
Considerando che l’autorizzazione per i vaccini contro il covid è all’uso di emergenza (EUA) e considerando che sono stati espressi dubbi sui vaccini Pfizer e Moderna circa la loro reale efficacia il diritto al consenso informato è oltre modo importante.
Se qualcuno si chiede se è moralmente accettabile portare avanti una scienza di morte la risposta per noi ortodossi è, nonostante alcuni nostri gerarchi, che non può essere accettabile.
Chiediamo allo stato e alle autorità locali preposte di garantire il diritto di obiezione di coscienza per motivi morali e di religione anche riguardo ai vaccini, come è garantito in altri campi, e di fornire, come ha il dovere, vaccini alternativi alle famiglie e agli individui che per motivi di fede si oppongono a questi vaccini.
FONTI:
National Center for Biotechnology Information. Corbett et al., Nature, 5Aug 2020.
van Doremalen et al., Nature preprint, 30 July 2020.
Istituto Europeo di Bioetica- https://www.ieb-eib.org/en/
Istituto Superiore di Sanità.
Il DOCUMENTO VIENE SOTTOSCRITTO DAL:
Direttivo dell'Associazione Testimonianza Ortodossa all'unanimità
Associazione Ortodossa San Giovanni Crisostomo.
Movimento Ortodosso in Grecia IC-CR-NICA.
Archimandrita padre Dimitri Fantini
Archimandrita padre Nettario Moioli
Archimandrita padre Arsenio Agioarsenita
Padre Popadiuc Ghenadie
Padre Giovanni Capparelli
Padre Costel Popa
Padre Michele Notaragelo
Padre Mario Sevini
Padre Ionita Mocanu
Monaco Michele Cristian Cavallo